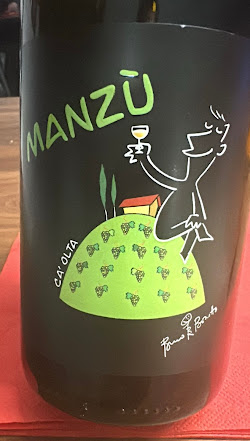BG, Riesling, Domaine Bott-Geyl.
Questo Grand cru d’Alsace, vigneto Schlossberg per l’esattezza, rappresenta una storia tipica di quella preziosa regione vinicola nel nord della Francia (una specie di “terra di nessuno” che ancora parla tedesco), Il nome dell’azienda ci fornisce lo spunto per argomentare questa tipicità: due famiglie storiche i Bott e i Geyl, uniscono in matrimonio due dei loro discendenti ed ecco formata una nuova, più grande, società agricola che mette a frutto le esperienze dei entrambi i ceppi famigliari. Certo, i Bott hanno già nel loro cognome il destino di vignaioli e cantinieri (si scherza, in realtà in francese botte si dice tonneau e in tedesco fass). E sta di fatto che oggi l’azienda, demandata agli eredi fin dal 1775, è ancora fiorente. Fedeli alle tradizioni ma innovativi nel tempo: ne è prova questa etichetta molto moderna, da grafica contemporanea, dove le iniziali dei due cognomi di famiglia diventano segno distintivo, marchio, e praticamente anche nome del vino. Si trovano in bella evidenza, in alto, con un croma arancione e in rilievo, scelta che non manca di farsi notare. Sotto al logo troviamo il nome aziendale per esteso e successivamente, dall’alto verso il basso, la stilizzazione di una vigna. Quindi il nome del Grand Cru, poi il vitigno e l’annata. A lato una fascia sempre in arancione vivido, dove vengono raccolte le ulteriori diciture di legge. Insomma, una Alsazia che guarda al futuro ma con i piedi ben piantati nelle propria terra d’origine e di elezione.