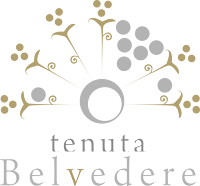Fara, Montepulciano d’Abruzzo,
Fabulas (Bio).
Fabulas (Bio).
C’è una precisa ragione, di più, una storia, che giustifica la presenza in questa etichetta di quei grossi fiammiferi accesi. A metà tra la leggenda e il romanzo. Ma andiamo con ordine. Il vino si chiama Fara e questo non va molto bene, considerato che, ufficialmente, esiste una Doc che si chiama proprio così: Fara ed è relativa all’omonimo paese dell’Alto Piemonte (insieme a Briona). Il disciplinare prevede la produzione di vini con un contenuto di Nebbiolo (clone Spanna) in prevalenza, con il possibile contributo di Vespolina, Uva Rara (alias Bonarda Novarese) e altri vitigni rossi piemontesi. Considerato che anche il nome “Fara” del Montepulciano d’Abruzzo di cui riportiamo l’immagine qui a fianco deriva da una località (in questo caso vicino alla Majella), la possibile confusione è dietro l’angolo (anche se i due territori sono molto distanti). Tornando ai tre fiammiferoni che si vedono nell’illustrazione che domina l’etichetta ecco cosa racconta il produttore nel proprio sito web: “C’era na vote... (c’era una volta) una comunità pronta a combattere gli invasori francesi, ma il rumore degli z occoli che ne ritmavano l’avanzata incuteva sempre più paura man mano che lo si sentiva più vicino. Era una sera del 1799, una di quelle sere in cui solo il miracolo di un santo poteva salvare i paesi abruzzesi arroccati lungo la vallata del fiume Foro. Si racconta che quella sera, in contrada Colle Selva, a Fara Filiorum Petri, un piccolo comune alle pendici della Majella, un anziano signore apparve dinanzi alle truppe francesi. I cavalli non vollero sentir ragione di proseguir la marcia e si inginocchiarono.
Il Generale francese ordinò: “dietro la cavalleria e avanti la fanteria” e in quel momento l’anziano prese le sembianze di Sant’Antonio trasformando le grandi querce del bosco della Selva in colonne di fuoco a difesa di Fara, costringendo alla fuga i soldati. Ogni anno, dopo Natale, i contradaioli di Fara Filiorum Petri si fermano una settimana per preparare la loro farchia. È una di quelle feste che esprime “appartenenza” alla propria terra, al proprio santo e alla propria gente. Di quelle dove si riesce a vedere l’Abruzzo più semplice, genuino e appassionato”. Niente male come racconto. Emozionale, territoriale, valoriate in senso eroico ed evocativo. Etichetta comunque fuori dagli schemi. Sia come design, sia come cartotecnica (sagomata). Originale anche la forma della bottiglia (intendiamo proprio il vetro), molto allungata, in stile alsaziano, che in centro Italia non t’aspetti.
Il Generale francese ordinò: “dietro la cavalleria e avanti la fanteria” e in quel momento l’anziano prese le sembianze di Sant’Antonio trasformando le grandi querce del bosco della Selva in colonne di fuoco a difesa di Fara, costringendo alla fuga i soldati. Ogni anno, dopo Natale, i contradaioli di Fara Filiorum Petri si fermano una settimana per preparare la loro farchia. È una di quelle feste che esprime “appartenenza” alla propria terra, al proprio santo e alla propria gente. Di quelle dove si riesce a vedere l’Abruzzo più semplice, genuino e appassionato”. Niente male come racconto. Emozionale, territoriale, valoriate in senso eroico ed evocativo. Etichetta comunque fuori dagli schemi. Sia come design, sia come cartotecnica (sagomata). Originale anche la forma della bottiglia (intendiamo proprio il vetro), molto allungata, in stile alsaziano, che in centro Italia non t’aspetti.