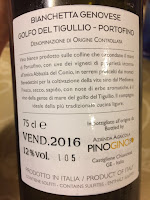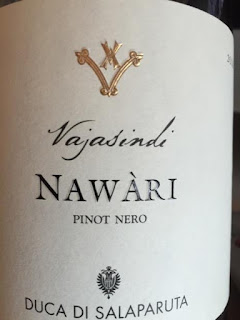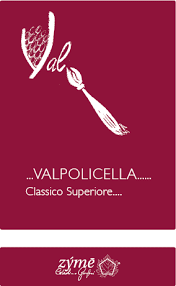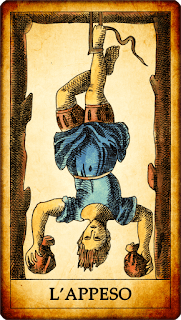CruPerdu, Franciacorta Brut, Castello Bonomi.
Questo Franciacorta prodotto con il 70% di Chardonnay e il 30% di Pinot Nero della medesima annata, si chiama "CruPerdu". Potrebbe sembrare lingua francese, o un francesismo, ma in realtà può essere ricondotto anche a un modo dialettale di significare... il suo significato. Ecco infatti la spiegazione del produttore che si può leggere nella pagina dedicata del sito web: "È l’estate del 1986 quando Luigi Bersini, Chef de Cave alla Bonomi, lasciando le vigne per dirigersi verso il bosco, scorse tra edere ed arbusti selvatici alcune piante di vite. Scoprì che il bosco, negli anni, si era impossessato di una porzione di terreno nascondendo un vecchio vigneto. La passione e l’amore per la terra hanno convinto il bosco a ritirarsi per consentire una seconda vita a quei preziosi filari. Il vigneto perso, il CruPedru, dona il nome a questa splendida cuvée". La storia, sia pure semplice, suscita interesse per due ragioni: in primis perché recuperare un vecchio vigneto è sempre, storicamente e qualitativamente, interessante. Secondo perché l'opera dell'uomo che riporta in vita la vite diventa encomiabile agli occhi di appassionati e degustatori. Certo che il vino avrebbe potuto chiamarsi anche "CruRecu", scherziamo giusto per dire che il senso di vigneto "recuperato" sarebbe stato ugualmente nobilitante. Ma insomma, una storia c'è ed è stata giustamente evidenziata, proprio a partire dal naming. Per quanto riguarda il resto dell'etichetta, la grafica, il packaging, l'impaginazione degli altri elementi presenti, possiamo notare la classica forma a scudo (molto presente nelle etichette della Franciacorta) che racchiude il nome e il logo del produttore (un castello ben stilizzato), mentre un tassello in basso isola il nome del vino. Etichetta molto classica, ben eseguita, ma che concede poco alla creatività e quindi all'emozione.